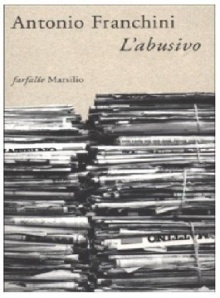 Almeno per quanto mi riguarda, in principio fu Antonio Franchini con L’abusivo. Un libro che è una meraviglia, scritto in un italiano nitidissimo. Ma anche un libro strano. Dentro c’erano due storie: quella del napoletano Franchini che vive e lavora come editor a Milano e quella del napoletano Giancarlo Siani che cerca di lavorare e muore ammazzato come giornalista a Napoli.
Almeno per quanto mi riguarda, in principio fu Antonio Franchini con L’abusivo. Un libro che è una meraviglia, scritto in un italiano nitidissimo. Ma anche un libro strano. Dentro c’erano due storie: quella del napoletano Franchini che vive e lavora come editor a Milano e quella del napoletano Giancarlo Siani che cerca di lavorare e muore ammazzato come giornalista a Napoli.
Le due storie sembrano i due filamenti a elica del DNA. Sono profondamente intrecciate, indissolubili, ma non si toccano mai. Siani e Franchini si conoscevano appena. A Franchini nessuno aveva chiesto di seguire quella vicenda, il suo lavoro era un altro.
L’assassinio del giovane cronista de Il Mattino è una vicenda contro cui il destino di chi scrive si staglia con nettezza in tutta la sua distanza e differenza. Da una parte le dichiarazioni in aula dei camorristi, dall’altra i viaggi in treno fra Napoli e Milano di un apprezzato editor di narrativa. Per ritagliare con precisione qualcosa c’è bisogno di uno sfondo che contrasta.
Nel proliferare di narrazioni di sé a cui si assiste oggi, è questo a caratterizzare davvero la cosiddetta autofiction. Che non è l’autobiografia del famoso di turno, non è un memoir su come si è sconfitta l’anoressia e non è nemmeno il Truman Capote di A sangue freddo che finisce mani e piedi in una storia che dovrebbe solo raccontare (e quindi perde quella giusta distanza). Assomiglia di più al Nanni Moretti di Caro Diario quando, sulle note di Keith Jarrett, conclude il suo girovagare per la Garbatella nel campetto di periferia dove fu ammazzato Pasolini. Nanni Moretti è l’ultimo intellettuale-guida della sinistra italiana, l’ultimo cineasta a ottenere un riconoscimento più importante di qualsiasi premio letterario o cinematografico: incidere alcune frasi nella memoria collettiva. “Faccio cose, vedo gente” o “di’ qualcosa di sinistra” sono diventati patrimonio idiomatico comune alla stregua di “uomini, mezzuomini e quaquaraquà” o “lavoratoriiii!”. Moretti, intellettuale apprezzato, coccolato e temuto, rende omaggio ma si autodefinisce appetto a Pasolini, l’intellettuale controverso, ribelle e sempre meno celebrato, anche dalla sinistra.
A quanto si dice, Il desiderio di essere come tutti di Francesco Piccolo sarà probabile protagonista del prossimo Premio Strega. Tre anni fa c’è stata la vittoria di Storia della mia gente di Edoardo Nesi e l’anno scorso Rizzoli ha portato sul podio Resistere non serve a niente di Walter Siti. Questi libri hanno qualche punto in comune. Con loro, l’autofiction esce defintivamente dal recinto dei side project rivolti ai fans più accaniti o allo sfizio d’autore. Si consacra come genere refrattario ai canoni, alla compattezza sinfonica, alle responsabilità del romanzo propriamente detto. Accosta pubblico e privato, cronaca e invenzione, Grande Storia e storia piccola, affetti ed economia, pamphlet e slancio proustiano. Lascia intendere con auto che allora tutti possiamo raccontare cosa facevamo l’11 settembre 2001 o quale sketch di Carosello ci piaceva di più. Ci fa dimenticare che fiction presuppone una quantità di strumenti che Piccolo, Moretti, Siti, Nesi e Franchini posseggono (al di là della riuscita delle singole opere, che nel caso di Piccolo e Nesi non mi sembra poi così straordinaria).
Ma più di tutto, l’autofiction sembra mettere in scena, nel suo stagliare la nostra scarlattina sullo sfondo del sequestro Moro, nel sovrapporre i turbamenti dell’io scrivente al Pertini esultante del Mundial, l’evidente mancanza di un ruolo che nessuna Patria, nessun Partito, nessun Padrone e nessun Dio ci ha più chiamato – o costretto – a svolgere. Per dirla con i Pink Floyd, ci è toccato a malapena a walk on part in the war, un ruolo da comparsa in mezzo alla guerra. E quindi, in definitiva, l’autofiction pare un affannoso tentativo di trovare qualcosa di grande e vivido contro cui stagliarci nitidamente ed uscire dallo sfondo, in un incessante desiderio, che è forse già nostalgia, di essere qualcuno.
-
Iscriviti
Sottoscritto
Hai già un account WordPress.com? Accedi ora.
